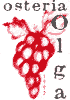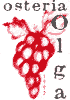|
Chi penserebbe oggigiorno di
scegliere come luogo di villeggiatura Maggianico (senza alcuna intenzione
offensiva nelle mie parole), se non fosse perchè vi risiede qualche
parente che ha il vantaggio di offrire un alloggio economico?
Ben
pochi, concedetemelo.
Non era così settanta o ottanta anni fa. Allora
le strade si inerpicavano pochissimo su per le montagne e i mezzi per
arrivarvi si limitavano quindi al cavallo di S. Francesco, economico, ma
scomodo. La scelta dei villeggianti cadeva perciò con facilità su
Maggianico e dintorni. Questo ridente paese però non offriva, a quei
tempi, la sola attrattiva di essere stazione di villeggiatura climatica,
turistica e di cura per la fonte, ma richiamava i forestieri anche per il
fatto che vi aveva piantato le tende un buon gruppo di artisti, facenti
parte di quel fenomeno che va sotto il nome di scapigliatura lombarda. In
questi giorni uno di costoro è tornato a far parlare di sè la stampa, il
musicista Carlo Gomez, dalla vita e da un' opera del quale, il Guarany, si
sta traendo un film. Film che viene girato in Brasile, essendo il Gomez
figlio naturale dell' Imperatore di questa nazione, trascurando così gli
anni trascorsi da costui a Barco, frazione di Maggianico.
Barco: un
nome che ora risuona ben di rado sulla bocca degli abitanti del
territorio. Di tutta l'erba si fa un fascio e i quattro rioni che formano
Maggianico vanno complessivamente sotto quest'unico nome. Barco è il
paesello che sorge lungo la linea ferroviaria a tre chilometri da Lecco,
sotto al Magnodeno, montagna popolata di castagneti e, un tempo, di molti
ulivi, ricca inoltre di acque fluenti in bianche cascatelle.
Il
Ghislanzoni ci dice che un secolo fa esso era “Un pacifico nido di
coloni dalla vita patriarcale”.
Le case erano schierate sulla
strada della chiesa; l'operosità industriale del territorio lecchese, pure
allignandovi con filande e opifici congeneri, vi faceva la figura dell'
intrusa. Sotto l'aspetto morale, il Ghislanzoni sempre ci ha rappresentato
Barco come 'Una confraternita cristiana, votata al lavoro, alle
aspirazioni ascetiche e alla preghiera.
La tranquillità del paesello
fu turbata improvvisamente allorchè nel 1850, un contadino assetato,
curvandosi per bere ad una sorgente smarrita tra gli arbusti, asserii con
disgusto che quell'acqua puzzava maledettamente di “Uova fradicie”.
Dall'accorrere di chimici e di medici, in seguito alla scoperta, ricevette
il battesimo una fonte minerale con acqua dotata di zolfo, magnesia ed
altri sali efficacissimi. Ciò risultò all'analisi fatta da Padre Nappi. Un
opuscolo del padre del Ghislanzoni, medico, propagandò l'acqua per la cura
di malattie varie, tra cui la gastro-enterite, l'epatite, l'uretrite. Nei
pressi della sorgente fu eretta una baracca di legno disadorna, battezzata
nientemeno col nome di caffè, e le due osterie del villaggio, con una
ventina di letti in tutto, ospitarono a fatica ammalati che accorrevano da
tutte le parti della Lombardia.
Mancavano quindi quelle comodità e
quelle attrattive che fanno la fortuna di un luogo termale (c'erano in
tutto due vasche per i bagni).
Gli uomini all'antica e gli amanti del
quieto vivere benedicevano questo stato di .cose perchè temevano, con lo
svilupparsi delle terme, un fiorire di scandali e di immoralità.
Sorse
finalmente un albergo, che veniva aperto al pubblico nella grande stagione
e che il Ghislanzoni trova male architettato ed insufficiente.
E
nacque, forse dal battesimo delle contrade con nomi fantastici e di
musicisti, una banda musicale con tanto di divisa.
Verso il 1875,
Barco cominciò ad acquistarsi una buona notorietà artistica. Il paesaggio
e la natura v'erano amiche con la calma, l'amenità, la bellezza, così che
le arti vi si davano convegno e le Muse fornivano le loro ispirazioni
copiosamente.
Qui gli artisti di ogni genere vi trovavano la pace
richiesta e il· desiderato contatto con la natura, tra quel verde in cui
il villaggio era ed è tuttora immerso.
Barco ospitò in quei tempi
musicisti come Amilcare Ponchielli e Carlo Gomez, poeti e giornalisti come
Antonio Ghislanzoni, concertatori come l'Appiani, violoncellisti come il
Braga, pittori come il Bignami e il Fontana, compositori come il Cagnoni,
il Dall'Olio e il Petrella. I musicisti, come si vede, eccelsero nella
brigata per qualità e numero. Venivano per ragioni di libretto, ma una
volta approdati subivano il fascino del luogo: con queste parole il
Ghislanzoni tratteggia efficacemente le ragioni della predilezione
mostrata dagli artisti per Barco. E al Ghislanzoni stesso spetta il merito
di avere richiamato in questo paesello i musicisti: egli godeva allora
fama di librettista principe e musiche famose nascevano allora sullo
schema dei libretti del poeta lecchese. (Vedi l'Aida di Verdi per tutte).
Il Ghislanzoni usò tutte le astuzie della sua eloquenza per convincere
gli illustri musicisti venuti da lui a rimanere in quel sereno paese non
esistendo in Europa una zona campestre più propizia al risveglio delle
ispirazioni e ... dell'appetito. E indusse il Ponchielli e il Gomez a
costruirvi perfino delle ville, spiccanti tuttora nell'edilizia del paese.
Musica e ... pranzi allettavano gli ospiti. Il Petrella, venutovi più
volte, andava pazzo per gli agoni e le trote. L'ultima volta che vi tornò
fu desolato perchè non riuscirono a pescargli una trota in tutto il lago.
Se non l'avesse sorpreso inaspettatamente la morte, dice il Ghislanzoni,
anche il Petrella avrebbe eretto la sua capanna a Barco, non fosse altro
per amor delle trote. I pranzi più prelibati venivano preparati dall'oste
Giuseppe Invernizzi, più noto come Davide, soprannome che costituiva anche
l'insegna dell'albergo.
Concorse anche costui, ma non solo con la sua
cucina, a trattenere gli artisti, innamorati del territorio: era un uomo
che, sotto una ruvida scorza, aveva un'intelligenza e un savoir faire
eccezionali.
La gloria di avere intrattenuto a Barca l'autore della
Gioconda spetta esclusivamente all'oste Giuseppe Invernizzi, lascia
detto il Ghislanzoni.
Chi nomina Barco, soggiunge Davide... Chi è
costui? Una grande energia paesana guidata dal buon senso più retto e
dagli istinti più onesti... uomo d'acciaio... personifica il progresso di
Barco... un coltivatore, raddoppiato di macellaio, di sensale, di
negoziante di pellami, di vetturale, di suonatore di tromba e di sindaco.
Vangando i terreni altrui, adunò il valsente per acquistarli... aprì
un'osteriuccia... comperò la casa.
Così il Ghislanzoni ci descrive il
Davide e termina, ultima ed efficace pennellata, col dirci che esso
è un'anima d'artista. Dell'arte ha
sortito gli istinti e, non potendo altrimenti, li manifesta colla
devozione e colla entusiastica ammirazione di chi l'arte professa.
Chiamatevi pittore, musicista o poeta e all'albergo di Davide le camerette
più confortevoli, gli intingoli più ghiotti, i vinetti più esilaranti
saranno per voi. E gli artisti non furono ingrati.
Il suo
albergo aveva sede nella casa che fu prima del Ghislanzoni e che costui
vendette per pagare il tipografo che gli stampava la Rivista minima,
fondata e diretta da lui stesso. Prova questa dell' indipendenza del
lavoro e delle idee del giornalista lecchese.
Tra le soddisfazioni
toccate al Davide per la sua fatica artistica, vi furono, graditissimi,
dei dipinti eseguiti a secco dal Fontana e dal Bignami, arguti scapiglìati
tra gli scapigliati, sulle muraglie dell'albergo. Un lavoro eseguito non
certo per acquistarsi gloria, su un'imbiancatura della scaletta che
portava ai piani superiori e lungo un terrazzo che dava sul cortile. I
dipinti raffiguravano una testa di donna e una baccante audace, circondata
da amorini che scherzano intorno ad un grandioso disco di polenta.
Completava l'opera una scherzosa iscrizione: “Questo dipinto nell' anno
1874 fecero colla massima indifferenza Roberto Fontana e Vespasiano
Bignami”.
Fu questo un gesto di riconoscenza al bravo Davide da
parte degli entusiasti artisti suoi ospiti.
Il Bignami ricordava
sempre l'accoglienza fattagli dal Davide, l'anno che questi si recò
personalmente alla stazione di Calolzio, ove era più comodo scendere, a
prenderlo con una vettura; e quando furono in vista all'albergo, il Davide
estrasse una tromba, cui diede fiato per solennizzarne l'arrivo
dell'artista, al quale toccarono inoltre festeggiamenti sontuosi, tra il
serio ed il faceto.
Il Davide prese invece successivamente sul serio
gli affreschi fatti in suo onore sui muri dell'albergo. L'estro degli
artisti venne sorretto, durante il lavoro, da bottiglie di vino bianco,
omaggio dell'albergatore. Venne il giorno dell'inaugurazione, con un
programma vario, tra cui inizialmente lo scoprimento dei capolavori. E il
Davide, buon uomo che era, si diede arie da mecenate. Ci fu un discorso
ufficiale del Bignami e l'incoronazione degli autori del dipinto da parte
di Re Davide che aveva in testa una corona di cartone e stagnola dorata e
un lenzuolo sulle spalle. Nel momento più solenne, tra l'attenzione viva
degli artisti, dei villeggianti e degli abitanti convenuti, immersi in
quell'aria scapigliata e goliardica, il naso di Davide afferrò da lontano
un odore di bruciato. Costui trasalì e, tra l'allarmato e il desolato,
abbandonò a precipizio il nobile consesso gridando: «Mè brùsa el rost ».
Mentre il Davide era, con la sua viva personalità il centro di questa
brigata di scapigliati, il Ghislanzoni ne fu l'animatore e il più costante
ed assiduo frequentatore. Interessantissimo conversatore dalla parlata
colorita e faceta, cui una piccola balbuzie conferiva ridanciana vivacità
ed efficacia, umorista completo ed umanissimo, satiro pungente e critico
provveduto per ogni arte, uomo intelligentissimo, sincero e ricco nella
sua povertà, poeta brillante, il Ghislanzoni riempiva con la sua figura le
riunioni della geniale e spensierata brigata di artisti di Barco. Quand'
egli stava nell'albergo del Davide, andava sempre a finire che tutti i
frequentatori si radunassero intorno al suo tavolo a godere delle
schioppettanti frizzatine verso tutti e tutto, degli arguti commenti agli
avvenimenti del giorno, delle profonde discussioni artistiche, degli
esilaranti aforismi che nascevano da quel convegno. Solitamente completava
e chiudeva la serata una cenetta a modo o una bicchierata senza risparmio
e, se era la stagione, una pentola di castagne lessate o una padella di
caldarroste, intorno alla quale facevano circolo artisti ed amici e il
Davide, alternantesi questi tra i clienti normali e l'allegra compagnia.
Un altro noto componente della brigata era, come già dicemmo, il
Ponchielli, di tutti il più famoso, che legò il suo nome al paesello anche
costruendovi una magnifica villa, tra la strada e la ferrovia, un po'
isolata dall' abitato, su un piccolo promontorio. L'autore della Gioconda
non era stato certamente nella sua giovinezza favorito dalla fortuna, nè
ben trattato dagli uomini. Dai suoi modi di fare e dalla sua figura
appariva subito il segno delle difficoltà che avevano ostacolato il suo
cammino in mezzo ad una società che non gli era benevola. Inabile alla
cortigianeria, fìdente nel suo valore, egli non seppe, nè volle usare
astuzie o strategie e puntò sulla sua potenza di mezzi per conquistare il
successo. Riuscì così a superare il periodo critico passato consumandosi a
Cremona negli esercizi più spietati che una città di prooincia possa
infliggere ad un maestro, come dice il Ghislanzoni. Dopo tanta ingiustizia
di cui furono oggetto lui e le sue opere, l'oscuro capobanda di Cremona fu
consacrato maestro al teatro Dal Verme, grazie ai suoi Promessi Sposi: fu
un successo strepitoso, che fece eco e lo sbalzò di colpo alla ribalta con
riconoscimento unanime dei suoi meriti. Avendo ancora nell' orecchio il
caldo fragore delle acclamazioni, il Ponchielli si ritirò nell' ambiente
sereno e propizio del territorio lecchese; il suo animo si ricompose dall'
emozione del successo e assaporò la gioia della natura felice di quei
luoghi. Vagheggiava la composizione di un idillio di arte e d'amore,
meditando sotto l'occhio delle verdi montagne e del ridente lago.
Abbandonò per qualche mese Lecco, per ritornarvi in compagnia della
cantante Teresina Brambilla, che aveva contribuito al successo dei
Promessi Sposi e alla quale egli s'era nel frattempo unito in matrimonio.
Trascorsero la loro luna di miele, coppia felice e bene assortita,
all'albergo del Porto, invidiati e ben voluti da tutti. Maestro acclamato
lui e cantante di vaglia lei, ma nessuno dei due si atteggiava a genio.
Trascorsero i loro giorni nei luoghi manzoniani, associando nel pensiero i
ricordi del romanzo a quelli dell' opera musicale. L'autore dei Promessi
Sposi, dei Lituani e della Gioconda, si innamorò così ancor di più del
territorio lecchese e pensò di costruirvi la sua casa. Dopo vari viaggi e
permanenze nei luoghi più ameni della nostra penisola, con negli occhi i
più incantevoli panorami che lo avrebbero potuto rapire, il Ponchielli
tornò al caro paesello dei suoi amori, pieno l'animo di nostalgia per le
cime ineguali, per le arcadiche selve, per le sottili cascate, per
l'azzurro lago. Si stabilì dapprima, strana coincidenza, dove già aveva
abitato l'autore di un altro Promessi Sposi, il Manzoni, nella villa al
Caleotto. Villa che, tre anni prima che vi ponesse dimora il Ponchielli,
fu abitata da Errico Petrella, autore di un' altra opera musicale dal
titolo I Promessi Sposi. Costui vi consumò i magri redditi della sua
fatica ed esaurì gli ultimi spiccioli del suo patrimonio melodico, mentre
il suo successore vi vagheggiò, dopo il primo trionfo, conquiste più
ardue. Il Ponchielli, mentre vi componeva la Gioconda, i Lituani, il
Figliol Prodiqo e i Mori di Venezia, passò sette anni di indecisione e di
incertezza per la scelta della posizione più adatta alla costruzione della
sua casa. A levargli ogni dubbio al riguardo, ci volle la ferrea volontà
dell' albergatore di Barco, il Davide. Era il sogno di questi di
assicurare al paesino, di cui era sindaco, la stabile permanenza
dell'ammirato maestro. Il Davide avrebbe vagheggiato la villa nei pressi
della famosa fonte; dovette comunque impiegare un' ardua battaglia per
convincere il musicista a impiegare in questo modo il gruzzolo che la
prima opera gli aveva fruttato. Dopo discussioni accanite e sopralluoghi
lunghissimi, la scelta cadde sul promontorio di cui dicemmo. Il Davide
uscì quindi sconfitto per ciò che riguarda l'ubicazione, ma l'aveva
spuntata per la cosa più importante: quella di trattenere il Ponchielli
nel territorio lecchese. Amilcare Ponchielli assorbì, dalla sbrigliata
compagnia che frequentava, l'abitudine e il piacere dello scherzo e delle
facezie. Capitava spesso dal Davide un caratteristico tipo di organista
che veniva per deliziare i signori con le sue melodie. Essendovi il
Ponchielli arrivato una sera, assente ancora l'organista, imitò i modi e i
gesti di costui e si sedette al cembalo facendone un'arguta e piacevole
parodia, che fu applauditissima. Terminato lo scherzo, corse via, forse a
chiudersi in casa, con l'animo ricolmo di nuove melodie ispirategli
dall'allegro giuoco in cui s'era esibito all'albergo.
Carlo Gomez, con
un carattere tutto l'opposto dell'amico, e cioè deciso e impaziente,
affidò al Davide quale suo factotum, l'incarico di occuparsi e di
sorvegliare i lavori per la costruzione della villa. Villa che sortì
sontuosa come un palazzo e con un vastissimo parco (circa 14 pertiche),
attraversato da un diritto viale. Il fabbricato è rasente alla ferrovia e
dista poco più di cento metri da quello del Ponchielli ..
L'impazienza
febbrile dell'autore del « Guarany » si comunicò a tutti coloro che
lavoravano alla costruzione, così che la fabbrica procedette a tutto
spiano. Non volendo sottoporsi al supplizio di attendere il compimento, il
Gomez decise di partirsene. Diede gli ultimi ritocchi al disegno ... -
narra il Ghislanzoni - chiamò il Davide e, ponendogli innanzi un bel
cumulo di banconote da lire mille, “Eccoti - gli disse - quanto occorre
per l'impianto della casa, addio! Tornerò fra otto mesi; dammi la tua
parola d'onore che alla sera dell'arrivo potrò dormire nella mia villa”.
Allorchè il focoso maestro tornò dal Brasile trovò che il Davide aveva
eseguito il mandato. Infatti l'albergatore ci teneva a queste cose in modo
particolare!
Era' così pronto l'ambiente ove il brasiliano avrebbe
composto i suoi spartiti che sarebbero seguiti al Guarany, al Salvator
Rosa, alla Fosca, alla Maria Tudor. Creò nuovi capolavori, sulle orme
dell'amico Ponchielli, come già ne aveva seguito l'esempio venendo a Lecco
per ragioni di libretto, e cioè per trovarsi vicino al suo poeta e per
trascorrervi poi la luna di miele. Il Gomez risiedette saltuariamente nel
nostro territorio e non fu, come gli altri, assiduo frequentatore del
Davide; preferì spesso la quiete del suo parco e la sontuosità della sua
villa alla compagnia scapìgliata.
Quasi di colpo la fortuna di Barco,
per un seguito di circostanze tramontò. Il Ponchielli chiuse la sua
giornata terrena, l'Appiani seguì la sua via, piena di successi, lungi dal
paesello di cui fu assiduo ospite, il Gomez vendette la sua villa e se ne
partì, il Ghislanzoni si chiuse in se stesso.
Terminò così il luminoso
periodo, durato circa un decennio, durante il quale Barco era assurto a a
fama nazionale e aveva vissuto giornate intense.
Affluirono ancora
villeggianti che prendevano il tono dell'ambiente, fatto di semplicità e
di cordialità, ma il numero e la qualità degli artisti andò via via
scemando.
Per qualche tempo ancora persone ammalate di pirosi, di
epatite o di qualcos'altro, convennero a Barco per lo stabilimento
balneario, non dimenticando peraltro di fare gli occhi dolci alle belle
lecchesi, che a quell'epoca si affollavano a torme sul luogo per
isfoggiarvi le trasparenze delle candide mussoline, fìnchè anche la
fortuna della fonte e delle terme non si oscurò.
|